VrumVrum, PotPot: tre voci raccontano l'umorismo surreale di Eronda
Leggi l'articolo

- Interviste
- |
- Pubblicazione: 17 ago 2025
L'uscita di VrumVrum, PotPot segna il recupero di un tassello importante dell'arte italiana del Novecento: le strisce di Mario De Donà, in arte Eronda, dedicate al rapporto nevrotico tra l'uomo e l'automobile negli anni Settanta.
Eronda rappresenta il tipico caso di "artista per intenditori", collocabile idealmente al crocevia fra i futuristi, Mimmo Rotella e Bruno Munari (di cui era amico e seguace), o associabile alle neoavanguardie del Novecento. La sua unicità diventa però comprensibile a tutti a un solo sguardo, se si considerano le sue strisce a fumetti: "onomatopeiche e motorizzate", mobili e vivaci nel segno grafico come nel lessico.
Erik Balzaretti, esperto e divulgatore di narrazione visiva, inquadra in questo volume il percorso artistico di Eronda restituendo a lettori di ogni generazione la dimensione surreale, raffinata e disincantata di una produzione dal valore elevatissimo. Completa il ritratto l'analisi acuta di Gianni Brunoro, che ne mette in evidenza l'approccio sperimentale e le diverse variazioni sul tema della strip.
Abbiamo raccolto le testimonianze di Marco De Donà, figlio dell'artista, dello stesso Balzaretti come curatore del libro e del Fondo Eronda, e di Brunoro come autore della postfazione, per comprendere meglio l'universo creativo di un maestro dell'illustrazione verbo-visiva.
La memoria del figlio: Marco De Donà racconta il padre artista
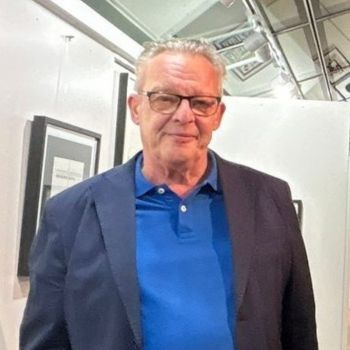 Da figlio, quali aspetti del carattere di tuo padre credi abbiano più influenzato la sua visione artistica e il suo umorismo?
Da figlio, quali aspetti del carattere di tuo padre credi abbiano più influenzato la sua visione artistica e il suo umorismo?
Definire il carattere di mio padre non è facile: leggiadro a un tempo, ironico al contempo, ma altrimenti molto severo. Credo che il sense of humor fosse semplicemente nella sua natura.
Come è nata l'idea di pubblicare VrumVrum, PotPot e qual è stato il tuo ruolo nel recuperare queste opere?
Dopo che mio padre è venuto a mancare, ho deciso di prendermi cura dell'archivio che aveva lasciato. È stata una lunga indagine tra cose che conoscevo, altre che ignoravo... Nella grande operazione del Centenario della nascita 2024, le strip, per vari motivi, non hanno trovato posto: ecco che (quasi per magia) è comparsa all'orizzonte Graphe.it, che con questo suo (delizioso) volumetto ha colmato una lacuna, un importante tassello!
Hai ricordi o aneddoti sul modo in cui tuo padre lavorava? Come riusciva a fondere tutte le influenze artistiche in uno stile così personale?
Mio padre è sempre stato molto "riservato" circa il suo lavoro e le sue creazioni artistiche. Il suo studio è sempre stato un "sancta sanctorum", raro accedervi, mai quando creava. A posteriori posso pensare che abbia fuso tante sollecitazioni, guardando con curiosità a quello che altri producevano, cercando ispirazioni che fossero utili al suo stile, comunque originale e personale.
Lo sguardo del curatore: Erik Balzaretti e l'universo verbo-visivo di Eronda
 Qual è stata la sfida principale nel presentare al pubblico l'arte di Eronda, così surreale e raffinata, ma poco conosciuta?
Qual è stata la sfida principale nel presentare al pubblico l'arte di Eronda, così surreale e raffinata, ma poco conosciuta?
Mario De Donà in arte Eronda è stato un artista e graphic designer che ha fatto del rigore metodologico e compositivo la sua cifra connotativa, anche nel campo dell'illustrazione satirica e umoristica tra gli anni Settanta del Novecento e i primi Duemila.
La sua caratteristica principale, e anche il motivo della sua relativa minore popolarità persino nel settore dell'umorismo grafico e della satira, è stata quella di non percorrere le strade più classiche del genere (dalla vignetta con battuta alle più nobili pagina/copertina illustrata d'autore surreal-umoristica a tema o la ricerca del segno comico e divertente), bensì la ricerca continua di uno straniante e corrosivo possibile fecondo intreccio tra parola, onomatopee e fono-simboli, e immagine in cui coesistono figura e simbolo.
Si tratta quindi di un modello iconotestuale, "sull'orlo del visibile parlare" come direbbe Giovanni Pozzi, che comprende il linguaggio ibrido del fumetto e del cinema d'animazione, ma al tempo stesso ricorda l'emblematica e le imprese di derivazione araldica, l'allegoria iconica, il concettismo visuale che ha prodotto i rebus, i giochi di parole e immagini e la poesia visiva concettuale. Il tutto al servizio della satira sociale e di costume letta alla luce di un raffinato umorismo.
Quindi la perfetta e apparentemente fredda logica del matematico applicata alla follia dissacrante del satirico e del colto umorista. Questo stile, molto poco frequentato in Italia ma utilizzato nell'ambito del design grafico per la creazione dei marchi d'impresa e in pubblicità, risulta meno diretto e quindi meno popolare. Si aggiunga che le illustrazioni sono realizzate con la tecnica del collage, anch'essa meno frequentata nell'umorismo grafico del disegno al tratto ma più vicina all'arte contemporanea.
Quindi con Eronda non si ride ma si sorride, spesso amaramente, come succede con la lettura e visione dei Caprichos di Goya. Bisogna metterci un pizzico di impegno per gustare appieno i doppi sensi linguistici e visuali di Eronda, comunque mai criptici o eccessivamente ostici e complessi, a volte disarmanti e surreali, ma ne vale la pena.
Aver riscoperto o, meglio, ripresentato questo autore, che nella sua carriera comunque aveva vinto premi ed era conosciuto nel settore a livello nazionale e internazionale, insieme alle sue opere particolari e preziose, è stato un onore oltre che un dovere per chi come me ha a cuore la disciplina dell'Illustrazione espressa nelle sue varie forme possibili. In realtà la vera sfida è quella che Eronda lancia al suo lettore, anche attraverso le strip, regalando come premio finale un divertimento intelligente e riflessivo ma anche solo un godimento estetico e intellettuale nella trasformazione in calembour verbo-visivi di un significante in un significato.
Come si combinano onomatopee, cinema d'animazione e giochi metatestuali nel segno unico di Eronda e nel suo umorismo surreale?
La dinamica compositiva utilizzata da Eronda risulta a grandi linee la stessa dei surrealisti, ovvero la negazione del senso comune per costruirne uno alternativo e polisemico che permetta di riconnettersi però a qualcosa di straniante che possa rimandare al senso primario.
Nel caso di Eronda, e in generale degli artisti verbo-visivi, si tratta di un procedimento circolare: la parola si trasforma in immagine e l'immagine si fa parola rincorrendosi l'un l'altra, esplorando tutte le possibili variazioni di senso nella logica della metatestualità e dell'iconotestualità.
Gli strumenti a disposizione sono, come detto, le onomatopee e i fonosimboli peculiari della rappresentazione del suono nei fumetti utilizzati poi in molti ambiti della comunicazione e arte popolare e contemporanea a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Le metafore in immagini disegnate che accompagnano il suono sono sempre state presenti nel cinema d'animazione.
Va segnalata, in questo senso, l'eccezionalità delle strip onomatopeiche abitate dalle stesse onomatopee che vivono visivamente il proprio significato verbale. Un processo che trasforma i suoni in immagine in personaggi auto esplicativi.
Invece nel caso delle strip in genere e quindi anche quelle di PotPot invece il processo è quello della premessa tradita o della promessa non mantenuta che sono un classico senza tempo del meccanismo della comicità che attraversa linguaggi e media diversi.
Strutturate come una modalità del fumetto umoristico, le strip di Eronda, anche per via del personaggio e della tematica legata al movimento, devono molto all'influenza del cinema d'animazione, dalle Looney Tunes a Tex Avery per arrivare al Bruno Bozzetto de Il Signor Rossi compera l'automobile e alla Scuola di Zagabria, e alle slapstick comedy del cinema muto o ai lungometraggi iperdinamici dei fratelli Marx.
La surrealità di questo tipo di umorismo è la caratteristica che contraddistingue anche il lavoro "a strisce" di Eronda. Il segno utilizzato è di stretta derivazione grafica e può ricordare un pupazzettismo realizzato per imitare la tecnica del collage, molto semplice e duttile nel caso di una possibile animazione. Quindi Eronda presenta delle strip che fanno del mimetismo grafico la sua forza, creando un'illusione visiva di trovarsi di fronte a un collage animato.
Mischiate il tutto, agitate e non shakerate, ed ecco a voi PotPot, personaggio dal nome onomatopeico del clacson-trombetta.
In che modo le strisce VrumVrum, PotPot usano l'umorismo per criticare la società e raccontare le nevrosi legate all'auto?
La raccolta di strip e illustrazioni qui pubblicata risale agli anni Settanta del Novecento e ha come focus il rapporto dell'uomo con la tirannia dell'automobile e del proprio essere automobilista in un periodo in cui ormai la luna di miele con il progresso portato dalle macchine era definitivamente finita.
L'automobile aveva ormai colonizzato l'umanità e aveva trasformato definitivamente l'essere umano in un cyborg viaggiante, nevrotico o adepto di una specie di culto. Lo stesso concetto di strada era mutato completamente passando da un luogo di passaggio a un incubo quotidiano tra file ai semafori, ingorghi e viabilità impazzita e dove la diffusione della segnaletica, con i suoi simboli imperativi e autoritari, aggiungono ulteriore tensione emotiva e attitudine surrealista che Eronda immortala perfettamente in una serie di illustrazioni a carattere umoristico.
Insomma, il personaggio di PotPot, nato per una rivista dell'Automobile Club bellunese, ha alle spalle tutte le riflessioni socio-antropologiche che dal secondo dopoguerra si erano succedute circa la psicologia dell'uomo, e poi della donna, al volante, declinate in senso umoristico e satirico circa i costumi socio-culturali degli italiani.
Cinema, cinema d'animazione, televisione, radio, teatro leggero, letteratura e fumetto: non esiste un media che non abbia veicolato il tema dell'automobilista e del rapporto tra l'uomo e l'automobile con tutte le sue appendici progressive e regressive che portano con sé vecchi e nuovi riprovevoli comportamenti rivisitati alla luce dell'imperante psicologia dell'uomo-massa.
Pedoni, ciclisti e guidatori accorti o no, subitaneamente reattivi, quelli definiti "della domenica", assumono il ruolo del nemico da combattere intanto che si inscenano parodie delle corse automobilistiche nelle strade, in città o sulle provinciali e nelle ancora modernissime autostrade.
D'altro canto l'industria automobilistica, e le infrastrutture autostradali che l'accompagnavano, insieme a quella dell'elettrodomestico e dell'alimentare, sono state l'asse portante per l'entrata nel mondo del benessere italiano connotato da una forte percezione di libertà e slancio nel futuro. Prima punto di arrivo e poi status symbol, "la macchina", intesa come concreto concetto di civiltà e progresso, trova nella classe media il suo habitat in-naturale e permette all'intellettuale e all'umorista di tracciarne vizi e nuove mode e convenzioni, riprendendo gli accenti critici, anche ideologici, verso l'industrializzazione e il suo impatto a livello sociale e individuale in termini di alienazione psico-sociale.
Dal luddismo a Tempi moderni di Charlie Chaplin il passo non è stato breve, ma da Il sorpasso, con il suo tragico finale, all'automobilista medio Cecconi Bruno di Paolo Panelli e dalla fantozziana Autobianchi Bianchina di Paolo Villaggio a L'ingorgo di Luigi Comencini il passo è stato brevissimo.
Gli anni Sessanta e Settanta del Novecento sono stati per l'italico automobilista la scoperta della doppia faccia del progresso che si credeva solo e sempre positivo, portando alla luce inquinamento e per gli umoristi e satirici come Eronda, una fonte di gag e riflessioni amare su quelle illusioni che si stavano dissolvendo tra innati e deprecabili vizi dell'animo umano rivestiti di nuove carrozzerie ma pronti a riemergere con prepotenza.
Eronda elabora questa enorme quantità di immaginario e di vissuto sociale in un tempo che aveva già perso l'innocente fiducia nel progresso tecnologico, riflettendo su una psicologia dell'automobilista ormai, in tutto o in parte, consapevole dei limiti del mito dell'automobile, ritraendo con PotPot uno specchio motorizzato dell'uomo medio destinato comunque a soccombere, questa volta consapevolmente, a un progresso tecnico in cui componente umana era destinata a un ruolo sempre più ancillare.
L'analisi del critico: Gianni Brunoro e il metafumetto di Eronda
 Come si inserisce l'opera di Eronda nel panorama delle strisce italiane nate con Linus e cosa la rende particolare rispetto alle altre?
Come si inserisce l'opera di Eronda nel panorama delle strisce italiane nate con Linus e cosa la rende particolare rispetto alle altre?
Dovremmo premettere che, in Italia, il formato "striscia" (forse meglio definibile "striscia autoconclusiva") è stato una conseguenza del successo editoriale della rivista mensile Linus, nata ad aprile 1965, che fece conoscere da noi il successo mondiale delle strisce di Charlie Brown (Peanuts, il titolo originale della serie). Il formato, in precedenza sconosciuto in Italia, ha avuto uno sviluppo imprevisto per cui vari autori italiani ci si sono cimentati.
Eronda, che come grafico aveva già a quel tempo una personalità contenutistica e uno stile del tutto personali ed eleganti, ha bensì aderito a questo movimento, sia comunque adeguandolo al proprio "mondo" (chiamiamolo così) sia soprattutto partecipandovi in maniera molto limitata. Da una parte ha prodotto per circa un anno, per una rivista automobilistica (cioè di settore) la serie di strisce PotPot, incentrate ciascuna non su argomenti di tipo tecnico, ma su temi di tipo ironico. Tutto sommato, sul piano quantitativo, fu una goccia nel mare della produzione italiana di quel tempo.
Più interessante è la produzione di Eronda concernente soluzioni in certo senso astratte. Ma questa, davvero minuscola, è però significativa perché ascrivibile a un filone di tipo metanarrativo.
Come è riuscito Eronda, con pochi elementi grafici, a raccontare la psicologia del guidatore italiano e i problemi legati all'auto?
Forse la striscia non è "pochi elementi grafici". A ben guardare, essa è costituita da una sequenza, in genere di tre quattro vignette, nelle quali l'autore presenta una situazione, la sviluppa e la conclude, in genere con una battuta o con una gag grafica: quindi – detto in maniera sintetica, perché poi ci possono essere più varianti – la striscia è una storiella autoconclusiva.
Su questo schema strutturale, Eronda ha costruito per PotPot situazioni basate sulle tematiche coinvolgenti la quotidianità dell'automobilista, da una parte con una stilizzazione elegante in bianco/nero di un conducente sulla sua automobilina; dall'altra sviluppandole concettualmente sui problemi pratici che il guidatore deve affrontare: sicché Eronda ironizza sui segnali stradali, sullo stato delle strade, sulle difficoltà poste dal tempo meteorologico, e anche su quello cronologico, visto che le nostre vite sono impostate su affannosi, ansiogeni problemi di fretta…
Puoi spiegarci meglio cosa si intende per "approccio meta-fumettistico" nelle strisce di Eronda e come questo le rende così speciali?
Ciò comporterebbe addentrarci in sottili problemi di natura semiologica, ma in questo contesto non è il caso, dobbiamo limitarci a una rudimentale semplificazione. Nel caso di una narrazione, c'è un "autore" che produce un "testo", per un fruitore-lettore. Il testo ha una sua autonomia e sulla identità dell'autore si può anche non sapere nulla; rimane sempre un ideale schermo che separa l'autore e il lettore. Ma se l'autore, nel proprio testo, si rivolge direttamente al lettore, dandogli – in senso lato – delle disposizioni, dei pareri coinvolgenti o così via, questo è un caso denominato "di metanarrativa".
La situazione si complica nel fumetto – espressione verbo-visiva – perché oltre l'autore produce un testo costituito da due parti: una verbale e una grafica. Ciò permette di realizzare situazioni bizzarre. Per esempio, i lettori di Cocco Bill, il surreale western di Benito Jacovitti, sanno bene che il protagonista può parlare con il suo cavallo Trottalemme (e questo ci sta, trattandosi di una serie umoristica e surreale, e loro sono personaggi del testo) ma capita che ora l'uno ora l'altro si rivolgano o all'autore o direttamente al lettore; oppure l'autore stesso può ritrarsi come personaggio e rivolgersi alle proprie creature (o viceversa) o addirittura al lettore. Evidenti casi di metanarrativa.
Eronda fa un passo in più (anche se abbiamo pochissimi suoi esempi del genere). Gioca, magari, con gli elementi costitutivi della striscia: per esempio, la cornice della vignetta che si destruttura e collassa su sé stessa, fino all'urlo finale "AHI!", diventa la sostanza stessa della storiella; accade anche quando la cornice medesima cade via via gradualmente a pezzi e diventa un cumulo di macerie. Sono casi di metafumetto.
